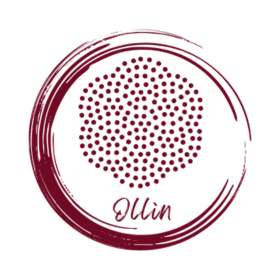Non me ne sono accorta subito. In realtà, per molto tempo non me ne sono accorta affatto, perché quando cresci dentro un certo modo di vivere le relazioni, quel modo ti sembra normale. Non lo metti in discussione, non lo guardi da fuori, non ti chiedi se esista altro. Lo respiri, lo impari, lo assorbi come si assorbe una lingua madre, e diventa il modo in cui interpreti ogni gesto, ogni distanza, ogni silenzio.
Ho imparato l’amore da chi mi ha fatto crescere, come tutti. Dalla mia famiglia, dalla scuola, dagli amici, dalle relazioni che ho osservato e da quelle che ho vissuto. E come tutti i bambini, non ho imparato da quello che mi dicevano, ma da quello che sentivo, da quello che il mio corpo registrava senza che io lo sapessi spiegare. Ho imparato che l’attenzione a volte c’era e a volte no, che la vicinanza non era qualcosa di scontato, che essere vista era qualcosa che, in qualche modo, dovevo meritarmi. E così, senza rendermene conto, ho iniziato a costruire una convinzione silenziosa: se mi impegno abbastanza, se faccio abbastanza, se sono abbastanza, allora mi ameranno.
Dentro, però, c’era una sensazione difficile da spiegare, un vuoto che non era sempre doloroso in modo evidente, ma che era costante, come un sottofondo. Un senso di mancanza che mi accompagnava anche nei momenti in cui apparentemente andava tutto bene, come se ci fosse sempre qualcosa che non arrivava fino in fondo, qualcosa che non si compiva davvero. E per anni ho cercato di riempire quel vuoto fuori da me, nelle relazioni, negli sguardi, nelle attenzioni, nelle parole che speravo arrivassero.
A volte bastava poco. Uno sguardo in più, un gesto di vicinanza, un momento di presenza. E quel poco diventava enorme, sproporzionato, quasi sacro, perché quando hai fame non valuti quanto cibo ricevi, senti solo il sollievo momentaneo di essere nutrito. Era come dare da mangiare a un affamato dopo giorni senza cibo: non importa quanto piccolo sia il boccone, il corpo lo vive come salvezza. E così quello sguardo diventava l’universo intero, e io ero pronta a dare ancora di più, a essere ancora più disponibile, ancora più attenta, ancora più presente, convinta che quella fosse la strada giusta.
Quello che non vedevo, o forse non volevo vedere, è che dopo quello sguardo passavano giorni, a volte settimane, di vuoto. E invece di mettere in discussione la relazione, mettevo in discussione me stessa. Pensavo che il problema fossi io, che se mi sentivo ferita era perché ero troppo sensibile, se mi sentivo sola era perché chiedevo troppo, se qualcosa non funzionava era perché non ero abbastanza capace di amare. Così ho iniziato a lavorare su di me non per crescere davvero, ma per essere accettata, non per esprimermi, ma per adattarmi, non per essere più vera, ma per essere più facile da amare.
Ho chiamato presenza le poche attenzioni sporadiche che ricevevo. Ho chiamato amore l’assenza, la freddezza, la distanza emotiva. Ho chiamato amore perfino la manipolazione, perché era più facile pensare che quello fosse amore piuttosto che ammettere di non essere amata. E soprattutto ho giustificato, ho giustificato silenzi, sparizioni, parole che ferivano, comportamenti che mi lasciavano svuotata, sempre trovando un modo per spiegare, comprendere, perdonare, aspettare.
Questa è forse una delle trappole più profonde che esistano: convincersi che l’amore sia qualcosa che devi guadagnarti migliorando te stessa, che se ti impegni abbastanza prima o poi arriverà, che se continui a dare senza misura, prima o poi qualcuno vedrà e resterà.
E in effetti, a volte, quella strategia funzionava. Arrivava un momento di vicinanza, una parola, un gesto, qualcosa che sembrava confermare che sì, quella era la strada. Ed era proprio questo il problema: non serviva molto per riaccendere la speranza. Bastava poco, pochissimo, e quel poco bastava a farmi dimenticare tutto il resto.
Col tempo, però, la conseguenza più grande non è stata il dolore. È stata la confusione. Non sapevo più distinguere l’amore dal bisogno, la presenza dalla paura di perdere, il legame dalla dipendenza emotiva. E così finivo spesso nello stesso tipo di dinamiche, anche con persone diverse. Cambiavano i volti, ma non cambiava la sensazione: quella di dover conquistare, mantenere, dimostrare, stare attenta, non sbagliare, non chiedere troppo.
Poi, a un certo punto, qualcosa si è incrinato davvero. Non per caso, non da solo, non lentamente per il semplice passare del tempo. Si è incrinato perché ho iniziato a lavorare profondamente su di me. Non è stato un processo romantico né leggero, e nemmeno immediatamente liberatorio. È stato duro, a tratti doloroso, perché ha significato attraversare proprio quel vuoto che per anni avevo cercato di evitare.
Ho dovuto restare dentro quella mancanza senza riempirla subito.
Ho dovuto sentire la solitudine senza anestetizzarla.
Ho dovuto guardare in faccia la realtà senza addolcirla.
E soprattutto ho dovuto comprendere qualcosa di essenziale: quel vuoto che mi sembrava così reale, così pericoloso, così insaziabile, non era più reale nel presente. Era un vuoto antico, un’impronta emotiva che continuavo a rivivere come se fosse ancora attuale.
Per cambiare il mio modo di amare ho dovuto imparare a chiamare le cose con il loro nome.
Ho dovuto iniziare a chiamare briciole le briciole.
Assenza l’assenza.
Manipolazione la manipolazione.
E, in alcuni casi, violenza ciò che per anni avevo chiamato amore.
Questo è stato uno dei passaggi più difficili, perché significava smontare il mondo che mi ero costruita dentro. Un mondo in cui avevo cercato di rendere accettabile ciò che accettabile non era, in cui avevo trasformato persone irraggiungibili in figure quasi perfette, e relazioni svuotanti in storie che, nella mia mente, avevano qualcosa di speciale, quasi di incantato.
Guardando indietro, ho capito che non erano favole.
Erano illusioni necessarie per continuare a restare.
E vedere questo fa male, perché significa riconoscere quanto si è stati disposti a tollerare pur di non sentire il dolore della mancanza.
Ma è anche ciò che libera.
Perché quando smetti di raccontartela, quando smetti di abbellire ciò che ti ferisce, quando inizi a vedere con chiarezza, qualcosa dentro si riallinea. Non è un cambiamento che avviene da solo, né qualcosa che arriva per caso. È il risultato di un lavoro su di sé, di uno sguardo sempre più onesto, di una responsabilità che a un certo punto non puoi più evitare.
Oggi non credo più che il problema fosse non essere abbastanza. Credo che il problema fosse aver imparato un’idea di amore che non nutriva, e averla difesa per anni come se fosse l’unica possibile.
E la verità, quella che fa più male e più libera allo stesso tempo, è questa: quando finalmente smetti di chiamare amore ciò che non lo è, per un po’ ti sembra di non avere più niente. Ma non è vero che non hai più niente. Hai solo smesso di nutrirti di briciole.
E quando smetti di nutrirti di briciole, all’inizio senti fame. Una fame che spaventa, perché non sei più abituata al vuoto. Ma quella fame non ti sta distruggendo. Ti sta disintossicando.
E solo allora, quando non accetti più le briciole, quando non confondi più l’assenza con l’amore, quando non ti racconti più che basta un gesto ogni tanto per riempire un mare di vuoto, diventa finalmente possibile qualcosa che prima non lo era:
non trovare qualcuno che ti ami,
ma diventare una persona che non è più disposta a chiamare amore ciò che amore non è.
OLLìN